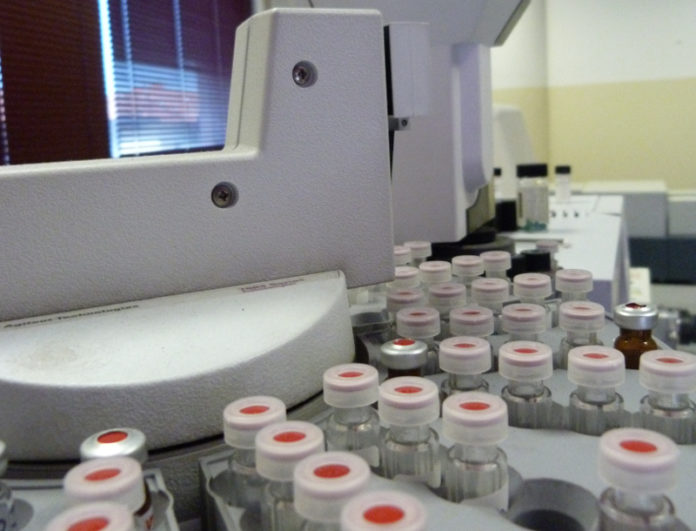Su cosa sia la vita e quale parte di quella che noi consideriamo vita abbia diritti e quali e quanti diritti sia giusto corrispondere ad ognuna di quelle organizzazioni biologiche che vogliamo definire come vitali. Questo è «il problema» da cui si parte per definire il nostro atteggiamento non solo nei confronti dell’essere umano vivente ma anche nei confronti di tutto ciò che, attorno a noi, è vivo, ha vita, ha sensibilità, reagisce agli eventi esterni e non infrequentemente li condiziona
> Gli articoli del dibattito
– Cara Caterina… – A proposito di talidomide…
Gentile Roberto,
non ho il piacere di conoscerti personalmente ma la condivisione della medesima cultura ecologista e l’opportunità di collaborare sulla stessa bella rivista mi danno la libertà di rivolgermi a te in tono amichevole e diretto, nella speranza che queste mie riflessioni offrano a te ed ai lettori di «Villaggio Globale» spunti per ulteriori approfondimenti, in linea con le parole, garbate, accorate ed approfondite, che hai usato per discutere, a partire dal caso di Caterina, luci (poche) ed ombre (tante, a tuo dire) della Sperimentazione Animale. Rispetto alla quale, dico subito per chiarezza ed onestà intellettuale, sono invece di parere diverso dal tuo. Consentimi quindi una riflessione un po’ più complessa ed articolata di quanto purtroppo non si sia abituati a fare in questi casi (ed, ovviamente, non mi riferisco di certo alla tua bensì alla presa di posizione di quanti intervengono sull’argomento producendo a volte più insulti ed anatemi che non ponderate e mediate valutazioni).
Abbiamo il diritto di chiedere più ricerca?
Il punto di base dal quale, credo, si deve partire è questo: se abbiamo o no il diritto di chiedere a noi stessi ed agli scienziati ricerca o più ricerca sui grandi temi del vivere, del soffrire e del morire. Tema affatto secondario e nemmeno superfluo se si pensa, come io ad esempio penso, che sia eticamente corretto chiedersi se tale diritto sia esistente in sé o se invece siamo di fronte ad una distorsione dell’attività umana o ad una non più indispensabile manifestazione dell’intelletto, magari piegata esclusivamente a logiche di mercato o a desideri narcisistici di taluni frequentatori di laboratori distanti dal mondo e dalle sue sensibilità.
Non ti paia, questa, una domanda da poco né un quesito privo di conseguenze, poiché invece sono in tanti che, legittimamente, affermano che oltre certi limiti l’uomo non può e non deve andare, che oltre certe risposte (già ottenute) c’è solo il raschiare il fondo del barile, col rischio di investire energie e risorse esclusivamente per scopi dalla nobiltà assai discutibile. Similmente a coloro che si chiedevano che senso avesse l’andare sulla luna (quando poi sulla terra i problemi sono numerosi e gravi) così oggi molti si chiedono (o possono legittimamente chiedersi) se ha senso e se ha un senso morale spingersi ancora in avanti in una ricerca che pare aver esaurito il proprio compito di speculazione intellettuale. Esattamente come Lord Kelvin nel 1900 affermava che ormai in fisica non c’era molto altro da investigare («Nella fisica non c’è più nulla da scoprire. Da fare restano soltanto misurazioni sempre più precise») l’idea può esser quella che dobbiamo solo affinare il nostro sapere senza sostanzialmente produrre nulla di nuovo perché di nuovo c’è poco altro. Inutile dire che Lord Kelvin nel 1900 si sbagliava ed altrettanto superfluo dire che io penso che ciò che abbiamo scoperto sino ad oggi non sia che una piccolissima parte di ciò che potremo arrivare a scoprire e che certamente scopriremo nel futuro.
Come si è fatta ricerca sinora
E allora il contesto in cui rispondiamo (o possiamo rispondere) positivamente alla domanda precedente ci porta a chiederci come sia stata condotta la ricerca sinora e con quali limiti essa abbia convissuto. Ebbene, e senza voler fare alcuna storia della scienza, possiamo affermare che la scienza e la ricerca hanno preso consapevolezza della maniera in cui potevano andare ad interpretare il mondo e cambiarlo nel momento in cui hanno saputo liberarsi dalle catene di una visione sostanzialmente religiosa del mondo la quale impediva le ipotesi, fermava gli esperimenti, annullava i risultati.
Una scienza capace di darsi un proprio metodo e finanche una propria etica al di là e al di fuori delle linee di pensiero che provenivano dalla cultura del/i tempo/i e che non potevano consentire tutto «l’altro da sé» di cui è espressione e veicolo la scienza stessa. La scienza ha fatto sempre battaglie di identità prima ancora che battaglie di contenuti nel momento stesso in cui ha scelto un metodo diverso rispetto al passato per comprendere le cose del mondo e le sue regole.
Quando Kant (con cui la scienza trova fondamenti logici per avviare la propria dirompente azione in un’epoca basata sulla metafisica e la religione) propone di passare «dalle percezioni alle analogie» pone le basi per quel metodo scientifico che poi, anno dopo anno e secolo dopo secolo, riuscirà a sollevare il mondo come, con un punto di appoggio ed una leva, si proponeva di fare Archimede duecento anni prima di Cristo.
I limiti storici della ricerca
In questo senso, in contesti certo diversificati e contraddistinti, i problemi che si sono gradatamente evidenziati nel fare ricerca sono sempre stati più chiari a posteriori che nell’epoca in cui si sono posti, ed è forse è anche per questo che noi oggi possiamo parlarne con maggiore compiutezza che nel passato.
Innanzitutto la ricerca col tempo ha dovuto affrontare la ricerca di un metodo. Un metodo capace di essere descritto e replicato, un metodo esente da contaminazioni legate alle visioni del periodo, un metodo condiviso e condivisibile. Sembra ovvio dirlo ma sappiamo bene che anche oggi non sempre è così e anche oggi molti, troppi, chiedono di denominare scienza quelle che sono impressioni, suggestioni, fascinazioni se non veri e propri plagi. Quando si afferma questo si vuole impedire la libera espressione dell’intelletto umano, si vuole limitare la capacità di astrazione del singolo, si vuole mettere un freno alla straordinaria creatività della mente umana? No, no di certo. Si vuole solo ed esclusivamente ribadire il fatto che, a fronte della massima possibilità espressiva del singolo o dei singoli, si rende necessaria ed indispensabile, una volta giunti ad una fase avanzata della ricerca, una condivisione metodologica e contenutistica dei risultati in maniera da garantire la comunità scientifica prima e l’intera cittadinanza poi sulla correttezza e sulla giustezza dell’intera procedura. Senza questi paletti non solo non si può andare lontani ma addirittura, a volte, si rischia seriamente di tornare indietro. Cosa che l’intelletto umano non può permettersi di fare.
È per questo che, per conoscere e capire, nella storia si sono effettuate cose abominevoli ed oggi improponibili, come studiare persone ancora in vita oppure provocarne volutamente la morte. Tutte cose che oggi guarderemmo e giudicheremmo con la più dura delle condanne ma che, ci piaccia o no, hanno fatto crescere il nostro sapere scientifico. Quello stesso sapere che oggi ci permette di sottoporci ad una appendicectomia o ad una colecistectomia senza temere granché. È stato un limite della ricerca scientifica, un grande abominio compiuto sulla pelle e sulle carni di poveri sventurati, ma che ha posto le basi della conoscenza del corpo umano così come noi oggi lo conosciamo, lo curiamo, lo proteggiamo.
Un limite quasi completamente superato dalla crescita culturale dell’intero mondo, oltre che della comunità scientifica in particolare; un limite che avendo fornito benessere a chi è vissuto accanto e dopo quei sacrifici è stato considerato «accettabile» o quantomeno rimosso dalla coscienza collettiva. Anche di chi, ancora oggi e giustamente, non può che inorridire dinanzi all’idea di aprire il torace di un vivente per comprendere le modalità con le quali il cuore spinge il sangue nell’organismo, esattamente come usava fare William Harvey nel 1600 quando si apprestava a scrivere il «De motu cordis». Senza cui, beninteso, non avremmo mai potuto salvare centinaia di bambini affetti da patologie cardiache e bisognosi di trattamenti chirurgici al cuore. Il mancato rispetto della vita dell’uomo ha prodotto scienza; un limite della scienza ha prodotto il superamento dei limiti della vita.
Col tempo si è potuto e saputo fare a meno di questa fase della sperimentazione (ma non dimentichiamo che ancora oggi, volontariamente e dietro compenso, molti uomini e donne si sottopongono a sperimentazioni di ogni genere, principalmente relative agli effetti di alcuni farmaci, senza che si sollevino ondate di stupore né di indignazione).
Le altre cose abominevoli si sono fatte su quelle espressioni della vita che più erano e sono vicine all’uomo, vale a dire gli animali, perché la necessità di verificarsi su un modello biologico il più vicino possibile a quello dell’uomo era stata vista (e lo è ancora) come strumento utile (e col tempo necessario ed indispensabile) per arrivare a conoscere le conseguenze di scelte, pratiche e trattamenti prima ancora di determinare effetti sull’uomo. I quali effetti sarebbero potuti essere impensati, imprevedibili e perciocché dannosi. La scelta di offendere ed usare la vita non umana per capire e curare la vita umana è stata sempre parte delle necessità della conoscenza medica, anche questa volta in un prevedibile coro di inquietudine e di dissenso. Inquietudine e dissenso, ricordiamolo, che nascono in anni relativamente recenti, quelli in cui (a mio modesto avviso correttamente) si comincia a comprendere la necessità di considerare la esistenza della sensibilità di ciò che è vita non umana ed ad attribuire ad essa peculiarità, dignità, libertà. Ancora una volta un limite etico della ricerca scientifica (medica in questo caso) ha determinato però il superamento di limiti di conoscenza e consentito di verificare ipotesi e strutturare soluzioni.
E non solo questo è stato ritenuto col tempo sempre più valido ed utile ma addirittura indispensabile e propedeutico, affinché nulla, ma proprio nulla, giungesse ad essere proposto all’uomo senza aver prima subito il percorso di verifica che si è ritenuto di affidare ad un metodo che, nelle sue fasi iniziali, doveva dimostrarsi non nocivo nei confronti di ciò che ci è biologicamente più simile ed affine (vorrei sommessamente ricordare a chi enfatizza le differenze fra uomo ed animale che le similitudini sono assai maggiori di quello che si pensi se è vero come è vero che fra ratto ed uomo c’è in comune ben l’85% del patrimonio genetico e che fra uomo e macaco c’è ben il 99% dei geni in comune). Così è stato sinora, per tutto, dai farmaci alle modalità di tecniche chirurgiche, e così è stato per rispondere alla domanda di conoscenza (condivisa) da un lato e di sicurezza (richiesta a viva voce) dall’altra. Nessuna voglia di pratiche sadiche o violente (il nazismo da una parte e certe attitudini di un mondo ormai quasi definitivamente scomparso dall’altra sono ben altra storia) ma solo la volontà di darsi delle regole: nell’interesse della scienza e nella garanzia dei fruitori. Cioè tutti. Cioè anche noi.
Il limite dell’offesa di uno schema metodologico è servito nei secoli a strutturare la possibilità di una «analogia dell’esperienza», senza cui avremmo brancolato nel buio della magia e della religione che dà la vita e la toglie in virtù di dinamiche a noi superiori; il limite dell’offesa alla vita ed alla dignità dell’uomo è servito a comprendere come siamo fatti, come viviamo e come moriamo, senza cui avremmo continuato a provare ad immaginarci senza poter mai verificare ipotesi e scenari; il limite all’offesa alla vita ed alla dignità dei non umani è servito a pre-vedere le possibili conseguenze delle nostre azioni sugli organismi, evitando che l’uomo stesso divenisse campo di sperimentazione e terreno di ricerca. Dai limiti si può imparare e la scienza, dei propri limiti, ha potuto fare tesoro. Un tesoro distribuito a tutti noi, sia i vecchi felici di giungere a novant’anni (con o senza badante) sia i bimbi sorridenti dopo un trattamento di trapianto midollare dopo aver sconfitto una leucemia (sia, infine e lo dico con una punta di malevola cattiveria, i pochi o tanti denigratori della scienza medica che sono spesso soliti correre dal medico per chiedere di sconfiggere senza tanti scrupoli il più banale dei raffreddori prima ancora che il più terribile dei tumori).
La questione della definizione di vita
Ho usato spesso, e volutamente, il termine ed il concetto di vita non umana al posto di vita animale e non è stato un caso. Avrei potuto porre lo steccato fra uomo ed animale, negando la giustezza dell’utilizzo di quest’ultimo nella ipotesi e nella pratica della sperimentazione pre-umana oppure sostenendola sulla base della consapevolezza di una diversità fra i due tipi di vita.
Invece no, ho usato consapevolmente il concetto di vita non umana perché credo che, a lato o dietro molte delle riflessioni che ci facciamo sull’argomento, stazioni un dilemma che non possiamo fingere di non conoscere o considerare. Quello su cosa sia la vita e quale parte di quella che noi consideriamo vita abbia diritti e quali e quanti diritti sia giusto corrispondere ad ognuna di quelle organizzazioni biologiche che vogliamo definire come vitali.
Anche questo, mi sia permesso dirlo, non è un problema da poco. Perché è «il problema» da cui si parte per definire il nostro atteggiamento non solo nei confronti dell’essere umano vivente (cosa ovviamente e «naturalmente» più semplice) ma anche nei confronti di tutto ciò che, attorno a noi, è vivo, ha vita, ha sensibilità, reagisce agli eventi esterni e non infrequentemente li condiziona.
Se il limite al nostro atteggiamento nei confronti dell’ipotesi sperimentale sugli animali è dato dal rispetto della vita dobbiamo essere pronti a confrontarci su cosa abbia quelle caratteristiche di vitalità, le quali sole hanno o avrebbero il diritto di richiedere per sé stesse medesimi diritti e peculiarità che siamo disposti ed educati ad offrire all’uomo. In altri termini la domanda è: possiamo sostenere che sia il fatto di esser dotati di vita propria ad imporci un atteggiamento simile o uguale a quello che offriamo ai nostri simili? O tale atteggiamento dobbiamo condividerlo solo con chi ci è più simile, nella scala biologica? E, in quella scala biologica che la scienza ha nei secoli organizzato (con studi che al momento in cui sono stati effettuati hanno avuto il limite di non contenere gli elementi di sensibilità che oggi noi chiediamo) a quale livello vogliamo/possiamo fermarci per concedere diritti ed opzioni? Gli animali sono viventi non umani, d’accordo. Sono i nostri più prossimi parenti, certo. Ma perché in una ipotetica concessione di diritti fermarsi a loro? E poi: a loro chi? Mammiferi? E perché non pesci? E perché non agli insetti? E i batteri, i virus, le spore?
Non solo. La vita come atto biologico è una sfida per la nostra capacità/possibilità discriminativa per concedere o no patenti di sopravvivenza, e conduce in sé una vasta serie di implicazioni scientifico filosofiche sulle quali bisognerà addivenire ad una qualche forma di accordo, se si vorrà gestire questa partita ricorrendo (ancora una volta, opportunamente) ad un «metodo». Altrimenti facciamo tifoseria spicciola senza rispondere ad altri istinti che non il nostro (comprensibile) affezionato attaccamento al vicino biologico di casa.
Forse la vita come elemento in sé non è sufficiente come criterio discriminante (insetti e miceti non apprezzeranno, certo, ma non risulta che a fronte dei programmi di derattizzazione o delle pratiche di disinfestazione dalla malaria qualcuno si ponga il problema dei ratti o delle zanzare come esseri viventi, sacrificati sull’altare del benessere degli uomini con i quali condividono il territorio).
Potrebbe essere quindi il criterio della capacità di relazionarsi intelligentemente con l’ambiente circostante a salvarci ed indirizzarci. O forse nemmeno quello. Già, perché di alberi capaci di condizionare non solo l’ambiente proprio ma addirittura il mondo intero (il dramma della deforestazione come elemento critico nella precipitazione degli eventi climatici lo dimostra in tutta la sua drammaticità!) come del resto di alberi che fioriscono felicemente se «trattati» con musica classica sono abbastanza piene le cronache (ricordo ancora con uno stupefatto sorriso l’esperienza di un noto conduttore televisivo ancorché agronomo di chiara fama chiamato a risolvere i problemi di vegetazione presso la propria villa di un notissimo cantante americano al quale, pare, avesse portato in fiore e ricondotto a buona salute le centinaia di alberi ivi presenti con la continua «somministrazione» della propria musica tramite altoparlanti). E se volessimo parlare di dignità di vita in relazione a criteri di presunta «autorevolezza» derivante dalla durata e quindi della continuità e quindi della memoria stessa non dovremmo dimenticare quanto i biologi ci raccontano, in ordine ad alcune balene della Groenlandia sui cui dorsi sono stati ritrovati arpioni del settecento, o all’Orange Roughy (il «pesce specchio» atlantico) ben più che secolare, o i grandi sauropodi del passato preistorico, o ancora, per stare nel mondo vegetale, agli alberi di Pinus Longaeva un cui esemplare californiano pare conti 4.844 anni. Per spingerci infine ad alcune spore batteriche riportate in vita una decina d’anni fa in laboratorio e ritrovati in cristalli di sale delle grotte di Carlsbad nel New Mexico risalenti, pare, a circa 250 milioni di anni fa: batteri, in sostanza, ancora più antichi dei dinosauri. Insomma, ci piaccia o no, ci crediamo o no, troveremo sempre ed a qualsiasi latitudine qualcuno disposto a giurare che anche gli alberi, anche le spore, anche i fiori o i frutti oltre che esser dotati di vita propria, vita non umana, sono anche dotati di capacità di ricezione di percezioni, sensazioni, emozioni. O di storia, di memoria, di passato oltre che di presente. Quindi vita complessa. Quindi vita in qualche modo simile a quella degli animali. Quindi vita in qualche modo simile a quella degli umani.
Un bel problema pertanto tracciare una linea di demarcazione, un gradino troppo alto per essere affrontato con le banali, mi sia permesso dirlo, armi della similitudine (o no) con i simili. Nel mondo che si è costruito tutto è troppo simile perché si possa agevolmente pensare di tracciare linee che demarchino politiche di condivisione e di discriminazione di diritti e di doveri. E la scienza non può che viaggiare in questa confusione demarcando a suo modo territori e creandosi giustificazioni: con i limiti ed i difetti, ma anche con tutte le ricadute possibili, che attengono al mondo di quella scienza ed ai suoi abitanti.
Come si potrà fare ricerca
Ecco perché, in risposta a coloro che sono perplessi sulla possibilità di sperimentare sugli animali, mi sono permesso di rispondere, in testa a questo mio contributo, che il dilemma non sta sugli animali bensì sulla ricerca e sulla possibilità/volontà di continuare ad attuarla. Perché se non si risolve compiutamente il percorso logico che ci fa scandalizzare di fronte all’idea di sperimentare un farmaco su un mammifero prima che su un bambino e non lo si conduce sino in fondo alla strada che dobbiamo per forza di cose chiamare vita (e che si approssima a noi con fattezze e caratteri non sempre così ovvi quanto per comodità vorremmo che fosse) si finisce per tifare per l’uno o per l’altro essere vivente, creando una condizione di oggettivo disagio per chi ha necessità di comprendere i meccanismi biologici più minuti (ed una altrettanto oggettiva condizione di inspiegato svantaggio e nocumento per tutte quelle altre forme di vita non umana alle quali ci arroghiamo il diritto di non riconoscere diritti). Se legge deve esserci che ci sia per tutto e tutti, verrebbe da dire (e via il bambino con l’acqua sporca, potremmo chiosare). Se deve esserci una legge etica della scienza questa non può che passare per il riconoscimento dell’identità del concetto e della condizione di vita, altrimenti quella legge, all’atto del riconoscimento e del disconoscimento dei diritti, diviene legge di potere, ribadendo una volta di più quella supremazia dell’uomo che proprio gli animalisti vorrebbero annullare.
E quindi, se vogliamo che la scienza si continui ad attribuire la possibilità di fare ricerca, dobbiamo (o dovremmo) porci il dilemma di quale ricerca e con quali prospettive, con la consapevolezza (questo sì ed esattamente come accaduto sulla sperimentazione sugli uomini) che ciò che la società condivideva o ammetteva sino a ieri potrebbe non esser più valido domani.
Quali regole per la ricerca
Se si vorrà continuare a fare ricerca, se la sensibilità generale sceglierà di continuare a fare ricerca (domanda dalla risposta ovvia e presumibile visto che l’impetuoso cammino della scienza è stato capace di sollevare montagne ed attraversare deserti sin dalla propria nascita), dovremo sempre più e sempre meglio esser capaci di formulare regole e percorsi.
Non che questi e quelle non ci siano, sia ben chiaro, ma da un lato le regole che ci sono necessitano di essere continuamente ribadite e ri-conosciute (gli uomini di scienza, si sa, o comunicano troppo poco o comunicano assai male: uno dei difetti di quel mondo!) affinché si comprenda sempre più il perché ed il come la ricerca scientifica seria viene effettuata e quali strade segue per darsi autorevolezza e mantenersi credibile. Così come dall’altro lato c’è la necessità di interrogarsi continuamente sulla possibilità/opportunità di sostituire metodi nuovi a procedure più tradizionali, sempre che le nuove riescano a fornire medesime garanzie e uguale sicurezza delle vecchie.
Il mondo scientifico internazionale, ad eccezione di poche rispettabili ma abbastanza isolate voci, è concorde nel definire come interessanti, utili ma non esaustive e comunque meno efficienti della sperimentazione animale in sede di validazione delle procedure scientifiche, quei metodi che vengono proposti in alternativa alla sperimentazione su esseri viventi.
L’uso di colture di cellule e tessuti umani non consente di prevedere le reazioni dell’organo intero o di organi che dialogano con quello in studio; l’uso di microrganismi ha il limite della molto maggiore complessità biologica dell’organismo umano; lo studio genetico (promettente, certo) si scontra con l’impossibilità a considerare l’interazione di quei geni con i fattori estrinseci che ne determinano la completa espressione durante la vita; la simulazione con modelli matematici ha la caratteristica di servire più ad ottimizzare le risorse ed indirizzare la sperimentazione che non a sostituirsi ad essa; le tecniche di imaging non hanno (ancora!) quella capacità di microdiscriminazione che si rende indispensabile per comprendere l’inizio biologico dei fenomeni in questione. Tutte cose già esistenti ed usate, non alternative di un futuro fantascientifico. Ma tutte tecniche dalle quali sappiamo abbastanza bene cosa (per ora) aspettarci ma delle quali conosciamo bene i limiti in sede di utilizzo investigativo. Si potrà migliorarne la sensibilità e la funzione, ne siamo sicuri, ma per ora ciò è ancora lontano dal proporsi come soluzione paritaria rispetto all’osservazione sul campo: il quale campo è l’organismo vivente.
Possiamo però, con la saggezza antica e la sensibilità moderna, tornare a ribadire i concetti di rispetto del metodo scientifico (se non lo facessimo torneremmo al medio evo), tornare a rafforzare le leggi del rispetto della dignità oltre che della vita dell’uomo (controllando zelantemente le modalità con le quali, ad esempio, in alcuni paesi poveri si può essere tentati dal compiere verifiche e sperimentazioni), ed avviarci a strutturare regole precise affinché vengano valutati e rispettati la dignità e la sensibilità dei non umani ai quali affidiamo il compito di provvedere a darci sicurezza e garanzie. Regole che già in parte ci sono ma sulle quali si potrebbe aprire un dibattito serio e preciso, privo di cadute di tono e di stile, finalizzato a corrispondere elementi di rispetto ad ogni vivente (anche proprio malgrado) coinvolto. È un discorso che deve essere fatto tutti insieme, la scienza, i filosofi, i cittadini, i politici, nella speranza di trovare elementi sintattici comuni che rifiutino le barricate e le semplificazioni demagogiche. Gli umani devono essere capaci di dimostrarsi capaci ed attrezzati per un’altra delle sfide che hanno costellato il loro lungo, impressionante cammino.
L’uomo sapiens sapiens e l’etica della responsabilità
E perché tocca farle, quelle regole, e perché tocca a noi farle senza la comodità di delegare ad altri esseri viventi? Perché l’Homo sapiens sapiens, insieme ai tanti danni inflitti al pianeta in cui ha dovuto imparare a vivere e insieme ai grandi innegabili successi di cui si è circondato, ha maturato, nella massima capacità di elaborazione cerebrale e mentale a disposizione di un vivente, un’etica della responsabilità che di norma non appartiene ad altri viventi.
Non che l’abbia sempre utilizzata, non che la metta sempre a disposizione dei propri procedimenti mentali e sociali, ma c’è. Ce l’ha a disposizione. Per questo tocca a noi. Capirsi e capire. Darci regole, condividendole, e modificarle quando, seppur giuste all’origine, hanno bisogno di essere attualizzate e modificate. O annullate e sostituite.
Solo attingendo alle indicazioni di un’etica della responsabilità si può oggi accettare di essere curati, come umani, togliendo la vita a viventi non umani, proponendosi di porgere loro come risarcimento metastorico i vantaggi complessivi di un miglioramento di vita sulla biosfera, che non può che essere all’inizio individuale o meglio di specie ma che, responsabilmente utilizzati, possono e debbono ribadirsi su tutti i viventi. La logica religiosa di presunta intoccabilità del mondo, altrettanto metafisica ed indimostrabile quanto quella cui si opponevano Hume e Kant nel Settecento, deve essere sostituita da una logica di altrettanto religiosa accettazione della necessità dello sviluppo (scientifico e non) responsabile e maturo. Solo che alla fede deve sostituirsi l’etica ed alla logica della metafisica deve subentrare un più alto livello di responsabilità.
Solo così potremo abbozzare contesti in cui muoverci compiutamente, solo così potremo capire il senso di una sconfitta all’interno di una più generale visione di progresso, solo così riusciremo ad incontrare, nel sorriso di un bimbo salvato, lo sguardo dell’animale che ne ha permesso la vita.
Discorsi pesanti come rocce, certo, indisponibili ad essere recitati con parzialità: di metodo, di giudizio, di posizioni. Discorsi che ci riconducono a dilemmi antichi che, come moderni, dovremmo però cercare di affrontare senza pietre in tasca e pregiudizi ingannevoli.
Faccio il medico ed in ogni momento mi pongo il problema di dare sollievo a chi sta male. Sul terrazzo di casa ho dieci splendidi gatti che mi fanno compagnia ogni giorno e sulla cui salute veglio affettuosamente come posso. Vorrei riuscire a continuare a fare le due cose, rispettando quella lucidità di giudizio e quell’etica di responsabilità senza cui la confusione regnerebbe sovrana ed il progresso (per malati e gatti) impedito.
Con stima.