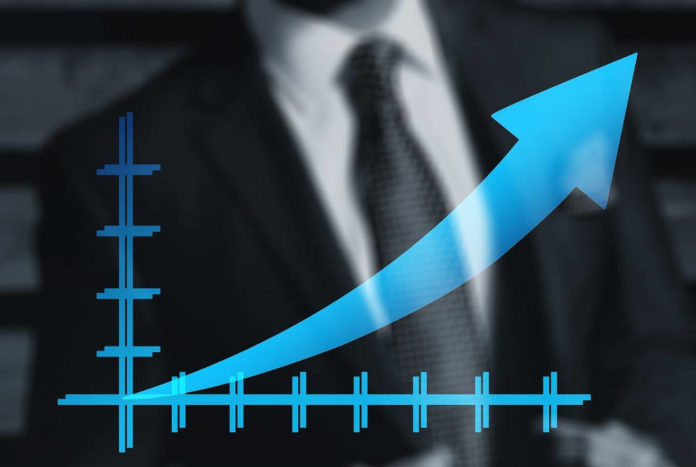Siamo diventati dei veri e propri «tossicodipendenti» della crescita; la tossicodipendenza da crescita non è soltanto una semplice metafora, ma è un fenomeno che può assumere forme diverse. Alla bulimia consumistica dei drogati da supermercato e da grande magazzino fa da contraltare la dipendenza da lavoro dei quadri, alimentata magari dal consumo di antidepressivi e anche, secondo alcune inchieste inglesi, dal consumo di cocaina per i quadri superiori che vogliono «essere all’altezza»
L’attuale momento storico, caratterizzato dall’emergenza Coronavirus, ci impone un seria riflessione circa la società in cui viviamo. Una società globalizzata e consumistica, una società che ha legato il suo destino, la sua ragione d’essere ad una organizzazione fondata sull’accumulazione illimitata. Un sistema del genere è condannato alla crescita. Non appena, però, la crescita rallenta o si ferma è la crisi, il panico.
L’occupazione, la spesa pubblica (istruzione, sicurezza, salute, giustizia, cultura, trasporti) presuppongono l’aumento costante e continuo del prodotto interno lordo, il famigerato Pil. Alla fine il circolo virtuoso (se così possiamo definirlo) diventa un circolo infernale. La vita del lavoratore si riduce a quella di un «organismo che metabolizza il salario con le merci e le merci con il salario, transitando dalla fabbrica all’ipermercato e dall’ipermercato alla fabbrica» (Cacciari P.).
I beni di prima necessità vengono dimenticati, anzi con essi lo stesso concetto di «bene di prima necessità» muta e la domanda passa dai beni di grande utilità ai beni di grande futilità.
Elemento necessario in questo nuovo processo è la pubblicità, che costituisce il secondo bilancio mondiale dopo gli armamenti, la quale si impadronisce dello spazio pubblico collettivo sfigurandolo.
D’altra parte, il ricorso al credito, necessario per far consumare quelli che non hanno un reddito sufficiente e agli imprenditori di investire senza disporre del capitale necessario, è un potente «dittatore» della crescita, del Nord e del Sud.
Si pensi che secondo la Federal Reserve, l’indebitamento delle famiglie statunitensi nel 2007 era pari a 28.198 miliardi di dollari, cioè ben oltre il 200 per cento del Pil. Quale che sia il nome per legittimarlo si tratta sempre del profitto, motore dell’economia di mercato e del capitalismo nelle sue diverse mutazioni.
Questa ricerca del profitto a tutti i costi avviene attraverso l’espansione del binomio produzione-consumo e la compressione dei costi. I nuovi eroi del nostro tempo sono i top manager che le imprese internazionali pagano a peso d’oro, strateghi che pensano soprattutto ad esternalizzare al massimo i costi per farli ricadere su dipendenti, clienti, generazioni future e, soprattutto, sulla natura divenuta al tempo stesso fornitrice di risorse e secchio della spazzatura.
Già nel 1950 Victor Lebow, un analista del mercato americano, aveva capito la logica consumistica. Affermava: «la nostra economia, immensamente produttiva, esige che noi facciamo del consumo il nostro stile di vita […] Abbiamo bisogno che i nostri oggetti si consumino, si brucino e siano sostituiti e gettati a un ritmo sempre più rapido» (Rapporto del Worldwatch Institute, «State of the World», 2000).
Siamo diventati dei veri e propri «tossicodipendenti» della crescita; la tossicodipendenza da crescita non è soltanto una semplice metafora, ma è un fenomeno che può assumere forme diverse. Alla bulimia consumistica dei drogati da supermercato e da grande magazzino fa da contraltare la dipendenza da lavoro dei quadri, alimentata magari dal consumo di antidepressivi e anche, secondo alcune inchieste inglesi, dal consumo di cocaina per i quadri superiori che vogliono «essere all’altezza».
L’iperconsumo dell’individuo contemporaneo «turboconsumatore» sfocia in una felicità ferita e paradossale. Mai gli uomini hanno raggiunto un tale grado di prostrazione. L’industria dei «beni di consolazione» tenta invano di rimediare a questa situazione. A tal proposito non si può non sottoscrivere la diagnosi di Dominique Belpomme: «La crescita è diventata il cancro dell’umanità».
A conferma di ciò, c’è la considerazione che se l’aumento del Pil e la crescita producessero automaticamente il benessere dovremmo vivere in un vero paradiso da tempi immemorabili. Invece è l’inferno che ci minaccia.
In questa situazione sarebbe urgente e utile riscoprire la saggezza della lumaca. La lumaca non ci insegna soltanto la lentezza ma, come ricorda Ivan Illich, «costruisce la delicata architettura del suo guscio aggiungendo una dopo l’altra delle spire sempre più larghe, poi smette bruscamente e comincia a creare delle circonvoluzioni stavolta decrescenti. Una sola spira più larga darebbe al guscio una dimensione sedici volte più grande. Invece di contribuire al benessere dell’animale, lo graverebbe di un peso eccessivo. A quel punto, qualsiasi aumento della sua produttività servirebbe unicamente a rimediare alle difficoltà create da una dimensione del guscio superiore ai limiti fissati dalla sua finalità».
Questo divorzio della lumaca dalla ragione geometrica, che per un periodo aveva anche lei sposato, ci mostra la via per pensare una società della decrescita, possibilmente serena e conviviale. Ma cosa era successo? Durante i cosiddetti «trenta gloriosi» (i tre decenni di sviluppo economico dal 1945 al 1975) era possibile denunciare i misfatti della crescita e dello sviluppo soltanto nel Sud del pianeta, dove erano più visibili in quanto producevano deculturazione, omologazione e pauperizzazione.
Ma anche nel Nord la deculturazione e la spoliticizzazione avanzavano a passi da gigante. Alcuni analizzavano e denunciavano questi fenomeni in modo più o meno acuto, come ad esempio Pier Paolo Pasolini. Il trionfo della grande distribuzione (super e ipermercati), dell’automobile e della televisione svuotavano surrettiziamente la cittadinanza, creando un «secondo popolo» quasi invisibile e senza voce, facilmente manipolato da un potere mediatico senza scrupoli, legato alle imprese multinazionali.
La globalizzazione, favorendo una grande dislocazione e lo smantellamento delle reti di produzione sociale, ha portato a termine la distruzione della cultura popolare.
Nicola Alfano